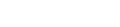ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
01/12/2026 | Press release | Distributed by Public on 01/12/2026 10:42
Trump riscrive l’ordine globale: cosa aspettarsi ancora nel 2026
Se il 2025 è già stato un anno vissuto pericolosamente, i primi dieci giorni di questo 2026 - per parafrasare, stavolta, John Reed - hanno sconvolto il mondo: la sequenza di azioni ed esternazioni di Donald Trump ha, infatti, pochi precedenti.
Cominciamo dall'intervento in Venezuela nella notte fra 2 e 3 gennaio. Prima domanda da porsi: è stato un vulnus grave, e forse definitivo, alla legalità internazionale? Grave sì, definitivo probabilmente (e sperabilmente) no. L'operazione più simile a quella condotta dalle forze speciali americane a Caracas è stata quella eseguita - sempre con successo - da George Bush (padre) contro il generale Noriega a Panama, nel dicembre del 1989. Altri tempi, certo, e altra amministrazione, ma all'epoca non provocò grandi critiche - neppure in Europa - e, soprattutto, non creò un precedente poi seguito da altri. Dal punto di vista strettamente militare, inoltre, il raid della Delta Force a Caracas richiama in parte pure quello dei Navy Seals ad Abbottabad, in Pakistan, nel maggio 2011, che portò all'eliminazione di Osama Bin Laden: certo, un leader terrorista e non un capo di governo (per quanto autoritario), ma anche in quell'occasione l'operazione diretta da Barack Obama fu sostanzialmente accettata, e per molti versi approvata.
Oggi la Cina di Xi non pensa a un'operazione del genere - in gergo, una "decapitazione" politica condotta da un commando operante sotto copertura - contro Taiwan. Anche se decidesse di ricorrere alla forza lo farebbe sulla base di criteri altri rispetto alla legalità (senza contare che la comunità internazionale ha da tempo adottato una One China policy, in virtù della quale Taipei non è comunque 'estero' per Pechino). Da parte sua, la Russia di Putin ha già cercato più volte di liberarsi di Zelensky (e di altri leader ucraini prima di lui) e persegue da tempo una politica di eliminazione sistematica degli oppositori, ovunque essi si trovino: la sua condanna della rimozione forzata di Maduro suona, insomma, piuttosto ipocrita. Ma è vero che sia Pechino che Mosca si preoccupano di solito di legittimare - sia pure artificialmente - le loro azioni di fronte ai governi e alle opinioni pubbliche: in questo senso, il raid americano in Venezuela può essere loro di aiuto sul piano della comunicazione. In ogni caso, la legalità internazionale non riguarda soltanto gli interventi militari, e perfino in quell'ambito è sopravvissuta - anche in questo secolo - a ben altre crisi. Ma, certo, la sua erosione continua, col rischio che l'eccezione diventi la norma. Pochi giorni dopo il blitz a Caracas, fra l'altro, la Casa Bianca ha annunciato l'uscita di Washington da altre 66 istanze multilaterali, fra agenzie ONU e convenzioni globali quali il Protocollo di Kyoto.
Le motivazioni
Russia e Cina si stanno inoltre chiedendo - senza forse trovare risposte univoche - se l'operazione in Venezuela costituisca un segnale di maggiore disponibilità all'uso della forza militare da parte di Trump (almeno rispetto alle dichiarazioni iniziali contro le "forever wars"), di un ripiegamento geopolitico sull'emisfero occidentale (le Americhe) a scapito di altre regioni, ovvero il risultato di una loro combinazione. Hanno comunque poco da rallegrarsi: Mosca ha perduto un alleato importante nella regione - con cui aveva appena firmato un trattato di cooperazione bilaterale -- e rischia di vedere anche l'altro (Cuba) indebolito dalla fine delle forniture di petrolio a buon mercato dal Venezuela. Non solo, ma per la seconda volta in pochi mesi -- dopo l'Iran nel giugno scorso - le batterie anti-aree di fabbricazione russa sono state rese inutili dal Pentagono (così come i radar forniti dai cinesi): tant'è vero che l'impiego, pochi giorni dopo, di un missile ipersonico Oreshnik contro la città di Leopoli, in Ucraina, può essere visto anche come una riaffermazione del proprio potenziale militare-industriale. Sia Mosca che Pechino, infine, possono ormai dire addio alle ricche risorse naturali del Venezuela.
L'intervento americano non è stato certo ispirato - come fu invece, almeno in parte, quello del 2003 in Iraq - dall'ideologia 'neo-conservatrice' che guidava alcuni membri dell'amministrazione Bush (figlio). Nella conferenza stampa tenuta poco dopo il raid notturno a Caracas Donald Trump non ha mai usato la parola "democrazia", ha apertamente delegittimato la leader dell'opposizione liberale Maria Corina Machado, e ha parlato sì di "transizione" ma in termini molto vaghi, lasciando intendere che ai quattro mesi di preparazione del blitz militare non si è accompagnata una riflessione altrettanto seria sul dopo-Maduro (un approccio paragonabile, almeno in questo, a quello di Cheney e Rumsfeld sul dopo-Saddam).
L'intervento in Venezuela non è stato neppure ispirato dall'ideologia MAGA, che rifugge anzi dall'attivismo internazionale e dagli impegni militari all'estero. In meno di un anno, fra l'altro, Trump ha già fatto più ricorso alla forza militare - fra missili, bombe e droni - di Biden in quattro, intervenendo in Yemen, Siria, Iran e, proprio a Natale, perfino in Nigeria. La stessa motivazione adottata, la complicità nel narcotraffico, appare oggi soprattutto una giustificazione giuridica per ottenere un mandato in base al sistema legale americano - e per poi diffondere le foto di Maduro bendato e ammanettato (come Saddam a suo tempo) - ed è durata, comunque, lo spazio di un pomeriggio. Piuttosto, l'intervento è stato guidato da vecchie fissazioni - già nel 2019 Trump (allora 45esimo presidente) aveva chiesto senza successo alla CIA di preparare un'operazione in Venezuela - e dall'evidente determinazione di (ri)stabilire l'egemonia di Washington nella sua storica sfera d'influenza regionale.
Si è parlato per questo di una "dottrina Donroe", con riferimento al quinto presidente (e ultimo fra i 'padri fondatori') James Monroe, che nel 1823 - sul finire delle lotte per l'indipendenza delle ex colonie ispaniche in America Latina - aveva voluto dissuadere le potenze europee dall'interferire negli affari di oltre Atlantico. Ma già sul finire del 19esimo secolo, all'originale spirito anti-coloniale della "dottrina Monroe" era succeduto lo slancio espansionistico culminato con William McKinley - il 25esimo presidente (repubblicano) ammirato da Trump anche per la sua passione per i dazi commerciali - che portò all'annessione di Hawaii, Portorico e Filippine e alla cacciata degli spagnoli anche da Cuba. E se la condotta e la retorica di Trump richiamano in parte l'interventismo di Washington in America Latina durante la guerra fredda (peraltro molto più sotto traccia, anche se non meno brutale), esse appaiono ispirate soprattutto da istinti 'imperiali' e perfino (con la loro enfasi ormai esplicita sul controllo delle risorse) neo-coloniali: i profitti prima dei diritti, insomma - da 'America First' ad 'Americas First'. E pensare che soltanto nel 2013 l'allora Segretario di Stato John Kerry aveva proclamato il definitivo accantonamento della "dottrina Monroe".
Alla luce delle successive operazioni della US Navy contro le petroliere venezuelane (e russe) nelle acque internazionali, infine, qualcuno ha parlato pure di gunboat diplomacy, la cosiddetta 'diplomazia delle cannoniere' delle vecchie potenze occidentali: l'imperialismo del 19esimo secolo con i mezzi del 21esimo?
Dietro a tutto ciò, tuttavia, non si riesce a intravvedere un'ideologia coerente, e neppure una vera e propria strategia, anche se in un'intervista concessa alla CNN il 5 gennaio Stephen Miller - vice Chief of Staff del 47esimo presidente ed architetto delle sue politiche anti-immigrazione - ha cercato di rivendicarla, esaltando il primato del potere e della forza nelle relazioni internazionali: "might is right" come recita un'efficace espressione inglese. Ma c'è senz'altro una visione: una visione che ora si mostra a tutti senza più filtri, come nell'intervista rilasciata appunto pochi giorni fa al 'New York Times' in cui il presidente, rigettando il diritto internazionale, ha indicato nella propria "moralità" il solo criterio che guida o limita le sue decisioni.
Le implicazioni
Il successo militare e mediatico del blitz in Venezuela - in meno di tre ore le forze speciali americane, forse assistite dall'interno, hanno sopraffatto una cinquantina di agenti di sicurezza (fra cui una trentina di cubani) senza subire perdite - ha galvanizzato ulteriormente Team Trump, portandolo alle minacce contro Cuba, Colombia e Messico, agli avvertimenti all'Iran investito dalle proteste popolari contro il regime, alla difesa ad oltranza dell'operato dell'ICE a Minneapolis, e perfino alla richiesta al Congresso di aumentare del 50% per il 2027 il bilancio del Pentagono, che già quest'anno supererà i mille miliardi di dollari.
Anche l'improvviso rilancio delle mire di Washington sulla Groenlandia - "ne abbiamo bisogno, assolutamente" - si iscrive in questa brusca escalation. Ancora una volta, l'idea non è nuova nè per Trump (che vi aveva già alluso nel 2019) nè per gli Stati Uniti. L'ipotesi di comprare l'isola dalla Danimarca era infatti circolata fin dalla seconda metà del 19esimo secolo, dopo l'acquisto dell'Alaska dall'impero russo; ed era poi riemersa alla fine della seconda guerra mondiale, con una proposta formalizzata nel 1946 (100 milioni di dollari in oro, pari a un miliardo di oggi) ma subito respinta da Copenhagen. Anche in questo caso, peraltro, la motivazione iniziale legata alla sicurezza - il presunto attivismo navale russo e cinese al largo dell'isola (smentito di recente dall'intelligence dei paesi nord-europei) - è presto passata in secondo piano rispetto all'esplicito interesse per lo sfruttamento delle risorse naturali di Nuuk e dintorni.
A differenza del Venezuela, tuttavia, la Groenlandia non è governata da un regime autoritario, né è coinvolta in traffici illeciti è parte del territorio NATO ed ospita (nella base di Pituffik) una presenza militare americana che - in virtù di un trattato bilaterale risalente al 1951 ed aggiornato nel 2004 - Washington può decidere già ora di espandere quando e quanto ritenuto necessario. Anche per il futuro della NATO e delle relazioni transatlantiche, dunque, non resta che augurarsi che fra le varie "opzioni" che l'amministrazione sta esplorando per l'isola prevalga quella del dialogo e del negoziato fra alleati: un primo incontro fra rappresentanti di Washington, Nuuk e Copenhagen, del resto, è già previsto nei prossimi giorni.
In tutto questo, forse, la sola buona notizia di questo inizio d'anno è stata la deliberazione del Senato americano - 52 voti contro 47, con cinque repubblicani schieratisi con i democratici - che ha posto vincoli ad ogni ulteriore intervento militare in Venezuela, così come il mese scorso (con addirittura 77 voti contro 20) aveva imposto condizioni alla riduzione delle forze americane in Europa.
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale published this content on January 12, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on January 12, 2026 at 16:42 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]